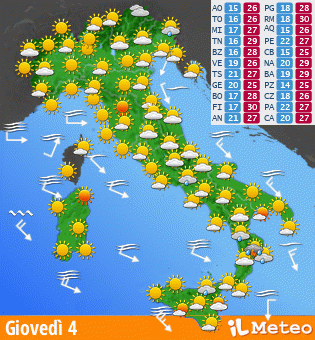S’è preoccupato solo di una cosa, lo schivo dottor Sergio Godi, che in vita sua non è mai finito sui giornali, anche se lo avrebbe ampiamente meritato: «Mi piacerebbe leggere in anticipo il mio necrologio. Non vorrei che si esagerasse...». L’ultimo desiderio di un condannato a morte. Si poteva non esaudirlo?
S’è preoccupato solo di una cosa, lo schivo dottor Sergio Godi, che in vita sua non è mai finito sui giornali, anche se lo avrebbe ampiamente meritato: «Mi piacerebbe leggere in anticipo il mio necrologio. Non vorrei che si esagerasse...». L’ultimo desiderio di un condannato a morte. Si poteva non esaudirlo?
Ecco, questo è il necrologio di un uomo nato a Verona il 13 settembre 1933, tuttora vivo e lucido, che misura il tempo a settimane, se non a giorni, ed è sicuro di non avere un altro compleanno davanti a sé. Sul New York Times sarebbe apparso a tempo debito nella rubrica Obituaries, in cui tutti i morti diventano buoni, bravi, onesti e belli. Sono titoli che al dottor Godi spettano di diritto e pare giusto attribuirglieli mentre è ancora su questa terra: buono è sempre stato, bravo lo era da far invidia, onesto tanto da non essersi arricchito sulle disgrazie altrui e ora persino bello nel suo pigiama blu notte a righette bianche, le cannule del drenaggio coperte da un lenzuolo, e addosso questa malattia che l’ha ridotto a pelle e ossa, gli ha ingiallito la sclera degli occhi sinceri epperò non è riuscita a piegarne il portamento da luminare d’altri tempi.
In Italia l’obituary è un genere giornalistico poco praticato. Più difficile ancora è scrivere il necrologio di una persona sapendo che lo leggerà. I pochi articoli custoditi negli archivi redazionali, pronti per essere messi in pagina al momento giusto, servono più ai sopravvissuti che ai cari estinti e si riducono a soavi esercizi d’ipocrisia. In gergo si chiamano coccodrilli, perché hanno la lacrima incorporata, ma è quella falsa, di circostanza, postprandiale, attribuita dalla leggenda al rettile che ha divorato la preda, quella disprezzata da Shakespeare, il quale fa dire a Otello: «Se la terra potesse partorire fecondata da lacrime di femmina, ogni goccia sarebbe un coccodrillo. Fuori dalla mia vista!». Sento che non s’addice a quest’uomo, anche se non ci siamo mai incontrati prima d’ora.
Per morire il dottor Godi è voluto tornare in ortopedia al Sacro Cuore di Negrar, in Valpolicella. Ed è soprattutto il suo reparto, non soltanto perché l’ha fondato lui, ma per avervi speso 28 anni della sua vita, dal 1970 fino alla pensione. I primi tempi ci ha lavorato da solo, sette giorni su sette, dalle 7 del mattino alle 6 di sera, 365 giorni l’anno, ferie mai.
Il dottor Godi era - no, è - uno specialista del piede. Ha girato il mondo per imparare - Boston, Filadelfia, Atlanta, Parigi, Francoforte, Zurigo - e altrettanto l’ha girato per insegnare le sue tecniche. A Verona una persona su due, fra quelle costrette a ricorrere al bisturi dell’ortopedico, cammina grazie a lui. Cinque-sei interventi chirurgici ogni mattina, per 28 anni, «solo per l’alluce valgo un anno arrivai a operare 365 pazienti, uno al giorno», moltiplicati per sei giorni la settimana: come minimo sono 30.000 interventi.
Adesso il suo medico è Nicola, il figlio di 37 anni. L’ex primario è diventato il paziente della stanza 495, il numero 5143 nella scheda nosografica. Ma qui resta una persona, anzi «el dotòr Godi», perché questo è l’ospedale voluto da un prete che nello statuto dettò, all’articolo 6: «Il malato è, dopo Dio, il nostro vero padrone». Un matto di Dio, don Giovanni Calabria. Un matto vero, che nel 1951 finì nella fossa dei serpenti e fu sottoposto dal professor Cherubino Trabucchi, direttore del manicomio di Verona, a quattro sedute di elettroshock. Ma aveva nella testa una pazzia che si chiamava santità e gli psichiatri non riuscirono a togliergliela. Ogni sera s’affacciava alla finestra della sua cameretta a benedire la città, dal colle dove il suo testamento spirituale oggi resta scolpito in una lapide: «Ti ringrazio, o Dio, per quello che mi hai dato, per quello che non mi hai dato, per quello che mi hai tolto». Papa Wojtyla lo proclamò santo. Poi, una domenica d’aprile del 1988, volle venire qui a Negrar e provò a consolare i malati mettendo da parte i foglietti del discorso, parlando a braccio: «Cristo ha detto: “Io sono dappertutto dove è la croce”. Dove è la croce, lì si trova Cristo. Vi auguro questa sua assistenza, superiore a tutte le assistenze».
Il dottor Godi porta la sua croce con serena dignità. Non aspetta miracoli, non recrimina, non si dispera. Aspetta solo che il destino si compia.
Si ricorda il suo primo incontro con la morte?
«Da studente di medicina. Il professor Mario Raso, illustre anatomopatologo, pretendeva che gli studenti del quinto anno partecipassero ad almeno 30 autopsie. La prima volta il cadavere era già adagiato sul tavolo settorio. Rimasi impressionato: non aveva la faccia. Poi capii perché: gli era stato rovesciato sul viso il cuoio capelluto per procedere alla craniotomia».
In che anno si laureò?
«Nel 1959, con Massimo Crepet, prorettore dell’Università di Padova, padre del noto psichiatra che si vede spesso in Tv. Fu generoso: 110 e lode. Ma fra i miei maestri ricordo in particolare il professor Bruno Polettini, docente di patologia generale. Era talmente severo che agli esami dava meno 2, meno 4. Una sera un gruppo di matricole gli gettò sulla testa un tabarro e lo riempì di bastonate».
Perché scelse l’ortopedia?
«Si trattava di una branca emergente, quindi presentava più sbocchi. Mio padre era un tassista a basso reddito. Come figlio di incapiente a Padova mangiavo e dormivo gratis nella Casa Arnaldo Fusinato e non pagavo le tasse universitarie grazie a una borsa di studio».
Aveva bisogno di guadagnare in fretta.
«Sì. Ma dal 1959 al 1963 lavorai gratis all’ospedale civile di Verona, col professor Enzo Marcer. Poi fui messo a libro paga: 30.000 lire al mese. Allora si andava a percentuale: al primario spettava il 50% del budget di reparto, a me lo 0,98%. Per fortuna nel luglio 1964 divenne ministro della Sanità il socialista Luigi Mariotti, che introdusse la regola del 421».
Cioè?
«Quattro al primario, due agli aiuti, uno all’assistente. Lo stipendio passò a 300.000 lire e così un mese dopo potei finalmente sposarmi con Pierina Gaspari, un’operaia del calzaturificio Rossi. A partire dall’anno seguente avemmo quattro figli».
Una storia proletaria.
«Mia moglie era volontaria della Croce verde. La conobbi nel reparto maschile. Saloni da 30 ricoverati, gambe in trazione, pazienti che urlavano. Nessuna infermiera voleva entrarci. Il primo giorno la sgridai perché si presentò con cinque minuti di ritardo».
Come arrivò a Negrar?
«Col dottor Carlo Bianchi, aiuto di Marcer. Dopo sei mesi, lui tornò in città, lasciandomi da solo. Era una landa. E oggi guardi che spettacolo di reparto: 55 posti letto, 4.300 interventi l’anno, quasi il doppio di quelli dei due ospedali pubblici di Verona messi insieme, nonostante qui i medici siano la metà».
Esserci ricoverato che sensazione le dà?
«Di avere una seconda famiglia. Ci ho trovato tre miei aiuti e 10 dei vecchi infermieri. Sono grato al primario Claudio Zorzi per avermi offerto questo letto nel quale chiuderò gli occhi per sempre. Qui mi sento a casa».
Vede una diversa professionalità, rispetto ai suoi tempi, nel personale?
«Molto più alta. L’umanità invece è un pochino calata. Non parlo di qui: in generale. Ma è tutto il mondo che va così. Spesso per i medici il malato diventa solo un numero. Si dimenticano che è un numero bisognoso di affetto, di una parola di conforto, di qualcuno che gli dica: “Non aver paura, ci sono qua io”. Anch’io parlavo poco, ma cercavo di fare tanto. Potessi tornare indietro, mi sforzerei di dire qualche parola in più ai miei malati».
Come si sta dall’altra parte della barricata?
«Si è deboli. Un po’ tristi. Il medico si crede un dio, è come se avesse ricevuto un’investitura. Dentro un letto d’ospedale non lo è più. Perde la corazza, si sente sconfitto».
Ai futuri medici che lezione vuol lasciare?
«Siate umili. Ero forte come voi, una volta».
Perché scelse questa professione?
«Per imitare il dottor Masotti, il medico condotto che veniva a casa nostra. Avevamo i cartoni al posto del soffitto, crollato durante i bombardamenti aerei nel 1945. Non chiedeva mai i soldi della visita. Gli sarebbe sembrato di rubare».
Da primario di che cosa aveva più paura?
«Di sbagliare l’intervento. Invece la diagnosi era facile: bastava una lastra. A quel tempo ci s’infilava il grembiule di piombo e si faceva in diretta la scopia all’arto. Un mio collega, Carlo Grillo, ha ancora le punte delle dita alterate dai raggi X. Le radiazioni gli hanno bruciato i polpastrelli. Quando si lavava le mani gli usciva il sangue».
Come ha scoperto d’avere un tumore?
«Due anni fa andando in bagno ho visto le urine scure e le feci color bianco latte. Ho messo alle strette l’ecografista: dimmi tutta la verità. “Niente di bello”, ha risposto. Aveva visto una massa che chiudeva il coledoco. Cinque giorni dopo il professor Paolo Pederzoli mi aveva già operato. Ricorrono a lui da tutto il mondo, il Policlinico di Verona è un centro d’elezione per il cancro del pancreas. Pederzoli ha fatto una bella pulizia. Pensavo di rientrare nel 20% di operati che a cinque anni sono vivi, anche perché i controlli eseguiti ogni sei mesi erano sempre negativi».
Invece?
«Due settimane fa un febbrone improvviso. L’ecografista non ha voluto dirmi nulla. Tornato in camera, mio figlio mi ha detto: “Papà, ti dobbiamo fare altri esami”, e s’è messo a piangere a dirotto. Sono stato contento, è stata la più grande attestazione d’affetto che potessi desiderare. Non avevo mai visto Nicola piangere. Neanch’io ho mai pianto».
Neppure per la morte dei suoi genitori?
(Ci pensa). «No, mai. È il mio carattere. Soffro dentro. Anche a mia moglie ho sempre detto: se devi piangere, non farlo davanti a me».
Sapere la data della propria morte è una sventura aggiuntiva?
«Una grazia di Dio. Ho potuto fare testamento. Però voglio dirle una cosa: ho smesso d’andare in chiesa dopo che la legge mi ha imposto, a 65 anni, di ritirarmi in pensione, mentre io avrei voluto continuare. Me la sono presa col Padreterno che non c’entrava nulla».
Poteva dedicarsi alla libera professione.
«Per qualche anno l’ho fatto. Ma un giorno proposi l’intervento in clinica privata a una paziente. Lei allargò le braccia: “Dotòr, benedèto, mi son la mojér de un operaio!”. Fu la peggior umiliazione della mia vita. Prospettare un’operazione a pagamento alla moglie di un operaio... Proprio io, che non ho mai inseguito i soldi e cacciavo dallo studio i tecnici delle ditte ortopediche pronti a offrirti la percentuale sulle prescrizioni di scarpe correttive. Giurai: mai più figuracce simili! Smisi di fare il medico quel giorno».
Intanto aveva perso la fede.
«Però qui in ospedale è passato a trovarmi il cappellano. Mi ha portato la comunione. Che male può fare un’ostia consacrata? Mi sono abbandonato. Non perché confidi nel paradiso: per la mia pace interiore. Adesso mi sento meglio. Chissà che cosa c’è di là. Il sacerdote non mi ha nemmeno confessato, ho solo recitato l’atto di dolore. Come disse Heinrich Heine in punto di morte, Dio mi perdonerà: in fin dei conti è il suo mestiere».
In 45 anni di matrimonio ha mai tradito sua moglie? Sia sincero. Semmai cancellerò domanda e risposta.
«Neanche col pensiero. Le sono sempre stato fedele, e lo stesso lei, credo, pur avendo dieci anni meno di me. L’ospedale non è riuscito a separarci. Trascorre qui tutte le notti».
Come si sente in questo momento?
«Stanco. Per fortuna non ho dolori».
Ha paura di dover soffrire?
«Sì».
Avrebbe preferito un infarto nel sonno?
«Magari...». (Sorride). «Ma c’è il pro e il contro anche nell’infarto: non avrei potuto salutare i miei cari».
C’è qualcun altro che vorrebbe salutare?
«Il dottor Giorgio Pravadelli, un medico in pensione. Abbiamo girato il mondo con i congressi scientifici: Russia, Cina, India, Nepal, Patagonia. Ma non voglio che mi veda in queste condizioni. Gli dico addio attraverso Il Giornale, di cui è un accanito lettore».
Temeva la morte più a 50 anni o adesso?
«Non l’ho mai temuta. Neppure adesso. Avevo solo paura di lasciare mia moglie con quattro figli piccoli. Oggi sono fatalista. Non spero più. Anzi, prima finisce e meglio è. Ho sempre rifiutato la chemioterapia, sarebbe stata solo un tormento accessorio. Quando la diagnosi non lascia scampo, a che servono le cure palliative? È inutile andare avanti».
Pensa all’eutanasia?
«Quasi...». (China il capo). «Purtroppo mia madre mi ha lasciato in eredità un cuore friulano che non cede».
Se un paziente terminale le avesse chiesto una puntura letale, l’avrebbe accontentato?
«No, mai».
Allora perché un suo collega dovrebbe praticarla al paziente Sergio Godi?
«Ha ragione. Da malato non posso chiedere ciò che da medico non potevo dare. Accetto quel che verrà».
Il famoso chirurgo Vittorio Staudacher prima di morire mi confidò: «Il malato vuol sentirsi dire solo una cosa: che guarirà».
«Tornasse qui a dirmelo il professor Staudacher, non gli crederei».
Il 1° maggio leggerà il suo necrologio. Contento?
«Sì, è un grande regalo. Carlo Bianchi, il medico che mi portò in questo ospedale, mi disse: “Muoio, ma spero di lasciare un buon ricordo”. Lo stesso io. L’ho fatto per i miei quattro nipotini, che non vedrò crescere. Sa, i bambini dimenticano in fretta...».
Non i nonni.
«Dice? Mi auguro che abbia ragione lei».
Come s’immagina il dopo?
«Una vita tranquilla, un mondo di pace. Spero di rivedere i miei genitori. Ma non so se sarà possibile».
| Naviga negli articoli | |
 Cosa succede dopo la morte? Cosa dicono le religioni, e cosa dice la Bibbia
Cosa succede dopo la morte? Cosa dicono le religioni, e cosa dice la Bibbia
|
LA BELLA LIRA ITALIANA - L'odiato Euro, dal 28 febbraio 2002

|
|
|